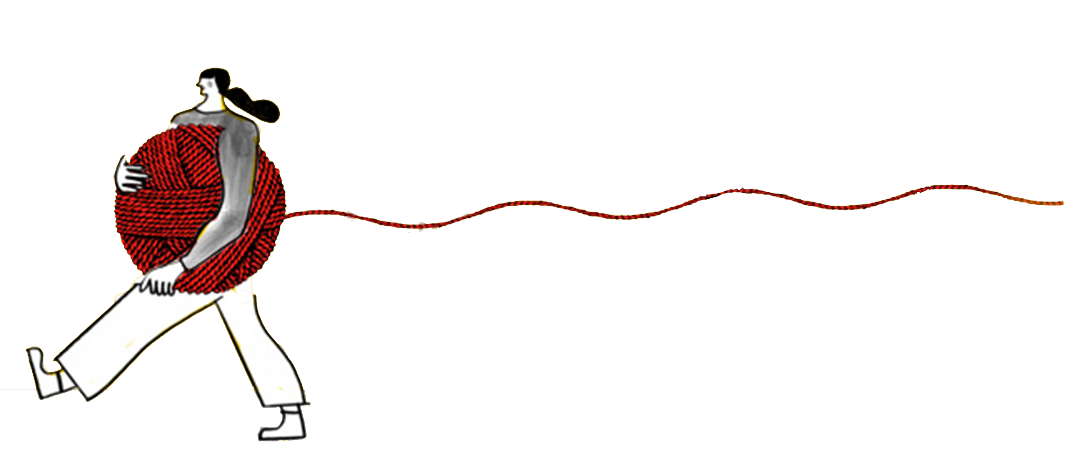Intervista al Vice Direttore de La Repubblica Carlo Bonini
Autore di numerose inchieste Carlo Bonini è un giornalista investigativo italiano, dal 2020 è vicedirettore de La Repubblica. Clicca per leggere la sua intervista.

Autore di inchieste scritte e video che hanno indagato le zone d'ombra della società, della politica e della legislazione italiana e internazionale, alcune diventate anche libri come "ACAB - All Cops Are Bastard" (2009), "Suburra" (2013), Carlo Bonini è firma storica del giornalismo investigativo italiano e, dal 2020, è vicedirettore de La Repubblica.
Per prepararci al suo corso di giornalismo d'inchiesta, a scavare a fondo, a interrogare i dati e a confrontare le fonti, gli abbiamo fatto qualche domanda.
Intervista a Carlo Bonini
Come è cambiato il modo di fare inchieste, se è cambiato, negli ultimi vent’anni?
Le regole sono sempre le stesse, così come il metro di valutazione della qualità del giornalismo d’inchiesta.
Sono cambiati significativamente le tecniche e gli strumenti di cui ci si può avvalere: il secolo digitale ha consegnato, a chi fa giornalismo d’inchiesta, un arsenale importante e impensabile solo trent’anni fa. Quando ho cominciato questo mestiere lavoravo con gli elenchi del telefono e con gli accessi alle prime banche dati sembrava di essere in un nuovo mondo: questo è già oggi archeologia.
D’altro canto, l’interconnessione rende i giornalisti investigativi ancora più sottoposti allo scrutinio dei lettori: sono aumentate la consapevolezza e l’avvedutezza di chi fruisce il giornalismo d’inchiesta, e questo significa che sono richiesti standard qualitativi e professionali sempre più alti.
Quali sono i suoi consigli per chi vorrebbe iniziare questa professione?
Innanzitutto leggere, non importa su quale piattaforma. Ed essere onnivori non solo sul piano della lettura, ma anche su quelli della ricerca e della curiosità: non ho mai creduto ai giornalisti chiusi negli specialismi.
La bellezza del giornalismo sta nella sua capacità di rendere fruibile una storia che entra in mondi di cui magari il giornalista nulla conosce, ai quali arriva come un qualunque altro cittadino, ma delle cui coordinate deve riuscire a impadronirsi velocemente per restituirli rendendoli intelligibili, strappandoli all’oscurità.
Dev’essere anche in grado di liberarsi dai pregiudizi: un buon giornalista è chi mette da parte il più possibile le proprie convinzioni profonde, che lo potrebbero ingannare o entrare in conflitto con quello che sta ricercando. Bisogna avere capacità di autosorvegliarsi da questo punto di vista.
Chi sono stati i tuoi maestri?
Il primo è stato Luigi Pintor de il manifesto, da cui ho imparato l’essenzialità e l’amore per le parole. Era ossessionato dal fatto che qualunque cosa scrivesse dovesse stare in quaranta righe: sosteneva che se avevi bisogno di più spazio per raccontare una storia è perché non l’avevi capita, e che la brevità l’obbligava a fare un lavoro di sottrazione e andare così all’essenza delle cose.
Altri maestri sono stati il collega con cui ho fatto un pezzo di strada, Peppe D’Avanzo, e anche i due vice direttori che ho avuto al Corriere, Antonio Di Rosa e Carlo Verdelli, che ho poi ritrovato qui in Repubblica come direttore. Da questi magnifici giornalisti ho imparato la complessità dello spartito giornalistico, la curiosità e il gusto di essere un irregolare.
Tutti e quattro condividevano una caratteristica: l’essere schivi. Mi hanno insegnato che in questo mestiere conta quello che mostri, il famoso “show, don’t tell”, che è poi una delle regole auree del giornalismo: non raccontartela, non raccontarti, mostra quello che hai scoperto.
Quali sono le inchieste che hanno cambiato o influenzato il giornalismo investigativo per sempre?
La prima è quella che mi ha fatto diventare giornalista: l’inchiesta permanente del Washington Post “Watergate”, che portò alle dimissioni del presidente repubblicano Nixon. L’inchiesta, condotta dai due reporter Bob Woodward e Carl Bernstein, non solo riaffermò il ruolo del giornalismo come cane da guardia del potere, ma dimostrò che in una democrazia sana il cane da guardia è in grado di difendere la casa da chi intende occuparla abusivamente. Fu uno di quei momenti in cui il giornalismo si mostrò al suo meglio.
È stata un’inchiesta a cui hanno guardato almeno tre generazioni di giornalisti, oltre che la pietra miliare e il benchmark a cui avvicinarsi anche per chi non faceva inchiesta ma cronaca.
La seconda è stata condotta dal Guardian e ha segnato un passaggio d’epoca. Aveva un format non molto diverso dal Watergate: anche qua c’era una “gola profonda”, un giovane funzionario dell’NSA, Edward Snowden, che ha consegnato la chiave con cui misurare il nuovo perimetro e il contesto in cui il nostro tempo è immerso. Un contesto digitale, in cui il possesso di dati, saperli processare e organizzare definiscono equilibri geopolitici decisivi, tanto nella vita dei singoli quanto quella dei Paesi.
Quale inchiesta avrebbe voluto realizzare e non ha potuto farlo?
Sono stato grato agli editori e ai direttori che ho avuto nel tempo, da cui non ho mai ricevuto un no: quello che non è finito su un giornale o su una piattaforma è stato perché non siamo riusciti a chiuderlo.
Però ci sono molte cose che avrei voluto fare: uno dei più grandi rimpianti è stato non poter continuare una delle inchieste di cui vado più fiero, che feci per Repubblica nel 2001, il mio primo anno in questo giornale, con il mio collega Peppe D’Avanzo. In sei puntate, raccontammo chi era Vladimir Putin, che allora per la prima volta si presentava al G8 di Genova come un Carneade: nessuno sapeva chi fosse questo grigio ex funzionario del KGB diventato Presidente della Russia. Lavorammo per sei mesi su questa inchiesta, spostandoci tra Svizzera, Russia e Francia, per provare a raccontare chi fosse quell’’uomo e il rischio e i pericoli che portava con sé.
Non ebbe grande fortuna con i Russi: alla seconda puntata, l’ambasciatore chiese formalmente che venisse sospesa e ottenne dal mio direttore di allora, Ezio Mauro, la risposta che meritava, “Queste cose accadono solo nell’Unione Sovietica”. E per anni non mi è stato permesso di rimettere piede in Russia.
E un’inchiesta che ha avuto fortuna?
Penso a quella sull’uranio nigerino, il Nigergate, che nel 2005 svelò come all’origine della prova manomessa che imputava all’Iraq di Saddam Hussein il possesso di armi di distruzione di massa ci fosse un pasticcio del nostro servizio segreto militare. Come per la storia della presunta prova che ha poi portato alla Guerra nel Golfo, questa era maturata in un oscuro appartamentino di Roma con un furto di documenti, che sarebbero stati manipolati in seguito in una piccola ambasciata di un piccolo Stato africano.
Pensando anche ad alcuni libri che hai scritto, secondo te perché siamo così affascinati dalla cronaca nera?
Uno dei motivi è la presenza nella nostra storia, già dall’epica e dalla tragedia greca, del male. È nella comprensione dei meccanismi del male che noi troviamo rifugio dalle nostre inquietudini più profonde e agiamo in modo simbolico.
Dentro ciascuno di noi c’è un animale imbrigliato: è per questo che ogni volta che vediamo quella parte dell’animo umano mettersi in movimento ne rimaniamo irrimediabilmente attratti.
Leggerne è un modo anche per liberarcene o fare i conti con quella parte: per questo la cronaca nera è uno dei generi giornalistici intramontabili, perché incrocia le nostre pulsioni più profonde.
L’altro motivo è che dà al lettore l’impressione di poter controllare una storia, fatto che non succede, per esempio, con le pagine di esteri o di politica interna. Di fronte a un fatto di cronaca nera, in divenire e ben raccontato, un lettore è in grado di controllare la materia che sta leggendo.
Ringraziamo Carlo Bonini e vi aspettiamo in aula a partire dal 31 marzo per il corso di giornalismo d'inchiesta.