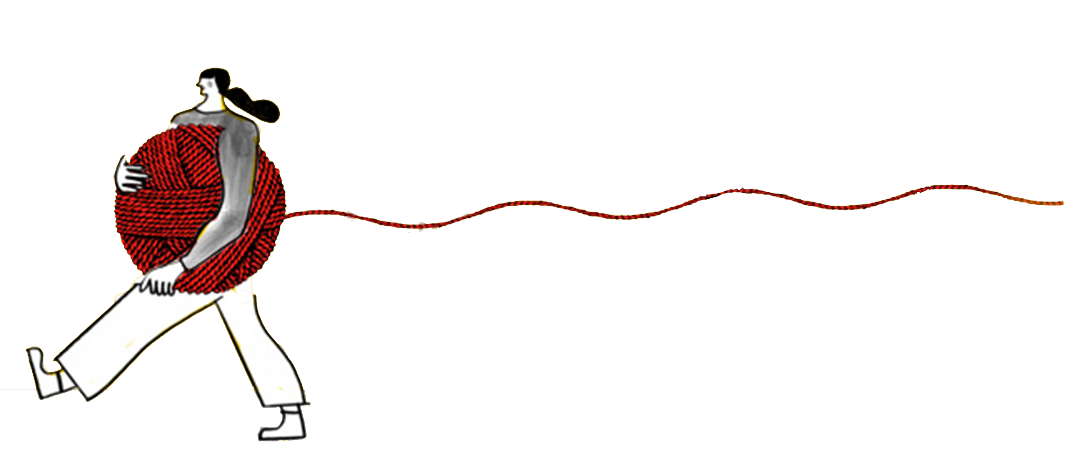"Il vero servizio al lettore si fa aiutandolo a comprendere": le sfide del giornalismo per Marco Damilano
Il direttore dell'Espresso Marco Damilano presenta il suo corso di giornalismo con FEdu e traccia le sfide per il presente e il futuro del mestiere, oltre i formati tradizionali ma con le tecniche di sempre.

Negli ultimi vent’anni, in coincidenza con l’affermazione del digitale, il giornalismo è stato spesso raccontato come un settore in crisi di vendite e di autorevolezza nei confronti dei lettori. Tuttavia, la domanda di informazione resta alta e di fronte all’ascesa dei nuovi media, il giornalismo appare piuttosto interessato da una fase di profonda trasformazione. Un cambiamento che apre opportunità inedite in termini di format e modelli di business ma che continua a fondarsi sul linguaggio e le tecniche che da sempre caratterizzano il mestiere.
L’importanza della scrittura e delle capacità relazionali, il racconto del potere, l’equilibrio tra oggettività e interpretazione: delle sfide aperte per il giornalismo del presente e del futuro abbiamo parlato insieme a Marco Damilano, direttore dell’Espresso e docente del nostro corso on demand di giornalismo.
Nell’immaginario collettivo il mestiere del giornalista è spesso associato alla capacità di scrivere. Di fronte alla varietà di media oggi a disposizione di chi fa informazione, quali sono per te le caratteristiche di un buon giornalista?
La scrittura è ancora importante, è la struttura di qualunque contenuto giornalistico. Se guardiamo a un secolo fa il giornalista era molto vicino a un letterato e la verosimiglianza di quanto scriveva era abbastanza incerta: con il fact-checking di oggi non so quanti articoli sarebbero sopravvissuti. Tuttavia, la scrittura continua a essere l’ossatura, quello che non si vede. C’è una scrittura per la carta stampata, i podcast, la radio, la televisione, la rete e i social. Quando penso alla scrittura penso alla connessione di fatti e alla loro sintesi. A prescindere dai contenuti, la scrittura rimane lo strumento principale.
Poi ci sono tante altre qualità del mestiere: è un mestiere molto artigianale che si muove su intuizioni, a volte addirittura colpi di fortuna o istinti animaleschi. Giusto ieri ho rivisto Frost/Nixon, la storia dell’intervista a Richard Nixon in cui David Frost riesce a costringere l’ex presidente ad ammettere le sue colpe e chiedere scusa al popolo americano. Lo fa sulla base di un contenuto, una ricerca sul caso Watergate, ma lo fa anche grazie alla forza con cui pone le sue domande.
Un altro tema importante, di cui non si parla abbastanza nella formazione, è il rispetto dei limiti in questo mestiere. Anche limiti di spazio-tempo, di struttura. Come sa bene chi fa un altro lavoro come quello dello scrittore, il limite è qualcosa che anziché ingabbiare evoca energie creative, perché ti costringe a superare un ostacolo.
Descrivi il racconto del potere come un lavoro di relazione e attenzione ai dettagli, ma cosa è cambiato da quando il dibattito politico si è spostato dal Parlamento ai social? C’è il rischio che siano i politici a dettare il racconto?
Il racconto politico è cambiato tantissimo. Prima la politica era prevalentemente il “Palazzo” ma era un palazzo molto rappresentativo, in cui partiti e istituzioni erano in qualche modo lo specchio della società. Si aveva l’illusione che raccontando la politica, quell’insieme che Pasolini chiamava “il Palazzo”, si potesse raccontare un pezzetto di società. Uno dei modi di entrare in quei meccanismi era il retroscena, per esempio.
Poi tutto è cambiato: penso a un articolo di Adriano Prosperi, uno storico, che raccontava il ribaltamento tra castello e piazza. Prima la piazza non vedeva quello che succedeva nel castello, dunque, il giornalista aveva il compito di raccontare quello che succedeva nel palazzo. Da qualche anno è il palazzo che non vede quello che succede nella società.
Il riflesso comunicativo di questo fenomeno è l’autoreferenzialità con cui i protagonisti del potere politico si propongono sui social e in televisione: sappiamo cosa mangiano e dove dormono, sappiamo tutto sui loro figli, ma non sappiamo in realtà niente, né di cosa pensano né delle loro idee di governo. Questo pone al giornalista un doppio problema. Una politica che pensa di superare le mediazioni, rivolgendosi direttamente alla società senza davvero conoscerla, e che si mette a nudo proprio per evitare le domande: il re è nudo ma se è lui a mettersi a nudo, non può essere denudato.
Tutto questo discorso l’avrei fatto anche prima del 21 febbraio 2020, ma c’è un dopo-Covid. Il Covid pone la questione degli “arcana imperii”, cioè delle modalità in cui prende decisioni un potere politico, economico o sanitario: dal virologo in televisione, all’OMS, ai grandi produttori di vaccini. Tornano i misteri, i segreti dei “castelli”. Di fronte alla pandemia ci sono state le chiusure, e anche il potere si è fatto più inaccessibile nelle sue logiche di emergenza, riproponendo temi antichi come il controllo e lo stato di emergenza.
Il giornalismo dovrebbe superare l’epifenomeno dei social, ma anche il precedente modello del retroscena politico, e cercare di scavare dietro i meccanismi decisionali. Non per inseguire complottismi anzi, il contrario: il giornalismo di qualità è l’opposto delle dietrologie e dei sospetti. Il giornalismo è come un fascio di luce in un angolo di oscurità e fare luce serve a evitare che nel buio i complotti possano diventare una notizia.
Si parla spesso di modelli di giornalismo alternativi, come quello di Le Monde, basato su un giornalismo lento e di approfondimento, che non sia solo un elenco di fatti. Perché in Italia non riusciamo a spostarci verso un tipo di giornalismo che sembra essere l’unico capace di rispondere davvero alle esigenze dei lettori?
Sono stato sempre addestrato ad andare oltre il puro fatto di cronaca. Il modello Le Monde è molto interessante, come anche quello del The Guardian. Ci sono dei problemi strutturali in Italia, le redazioni sono ancora organizzate per sezioni e non sono connesse. Faccio un esempio recente: la Super Lega, è un tema sportivo, politico o economico? L’organizzazione del lavoro è ancora spesso legata a queste specializzazioni.
L’Italia poi ha una specificità, comune anche alla Francia, ovvero l’assenza di una stampa popolare. Questo ha favorito la diffusione di quotidiani omnibus dove argomenti alti convivono con altri popolari. Questo ha spinto i quotidiani a essere un po’ di tutto: una stampa generalista e di servizio che ha rafforzato l’idea che la stampa non approfondisca certi temi o opinioni. Ogni giornale si vive come un’isola a sé, come se esistesse un lettore che non ha altre fonti di lettura.
Bisognerebbe tornare a dire che avere un’identità precisa non significa recintarsi in un’ideologia, ma significa fornire una chiave di lettura che non è quella di tutti. Il servizio al lettore si fa aiutandolo a comprendere. Penso che il giornalismo sia molto più di un semaforo che valida o meno un fatto. C’è giustamente una pretesa di oggettività, ma anche i dati e i numeri vanno capiti e contestualizzati, nel tentativo di farsi domande e a volte darsi risposte scomode.
In questo contesto di trasformazione, quali sono in Italia oggi gli spazi per fare giornalismo?
Io parlo di giornalismi, al plurale, perché penso sia necessario superare le gabbie. Anche nella mia esperienza di direttore dell’Espresso vedo quanto sia variegata l’offerta di contenuti giornalistici: si va dal fotografo al videomaker, fino al giornalista in senso classico, oltre gli schemi dell’appartenenza all’ordine e dell’inserimento in una redazione.
Ci sono delle differenze tra chi fa questo lavoro all’interno di queste gabbie e chi le rompe, anche se l’idea che si è affermata durante la pandemia è che chiunque possa fare questo mestiere. L’onnipresenza del giornalismo è un’apparente debolezza dell’informazione professionale. Chiunque può accendere lo smartphone e raccontare una manifestazione, un terremoto; chiunque può mettere in scena, in rete, un racconto. Non si tratta però necessariamente di un racconto giornalistico, è il materiale che forma il racconto giornalistico.
Per realizzare quel particolare tipo di linguaggio, serve qualcuno che per esperienza, studio, lavoro redazionale e conoscenza dei suoi limiti, abbia una strategia: per proporre un pezzo se si lavora in una redazione, per adattare il proprio linguaggio a diverse piattaforme, per riconoscere cos’è davvero una notizia.
Tutto questo non è più incluso nella gabbia del giornalismo tradizionale, fa parte di una produzione di contenuti molto più ampia che parla però un linguaggio comune. Dobbiamo cominciare a concentrarci non più sulla gabbia ma sul tipo di linguaggio.