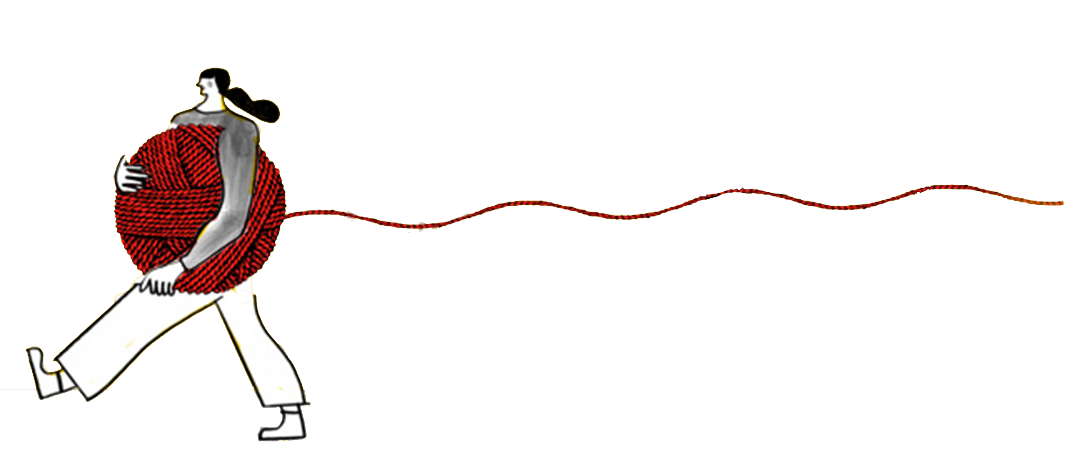Il salto in avanti da fare per accelerare davvero la digitalizzazione
La tecnologia si è rivelata una soluzione indispensabile durante la crisi Covid-19, ma non è necessariamente la soluzione preferita per tutti per il dopo. Gli italiani sono gli ultimi in Europa nelle conoscenze digitali. L’unica via d’uscita è la formazione
Nel febbraio del 2020, gli italiani occupati nella modalità dello smart working erano meno di 600mila, secondo il Politecnico di Milano. Anche se almeno 8 milioni avevano funzioni da knowledge worker che potevano essere svolte da remoto, registrava l’Istat. Di fatto, durante le varie clausure decise per contrastare la diffusione del Covid-19, il 56,4% degli occupati italiani, che sono 23,8 milioni, ha potuto lavorare da remoto, calcola il Censis. L’orribile anno 2020 ha accelerato, forzosamente, la digitalizzazione in Italia. E questa esperienza lascerà un segno. Sempre secondo il Censis, 3,5 milioni di lavoratori continueranno a operare da remoto anche quando l’emergenza sarà finita.
Nel frattempo, sempre nel 2020, si è registrato un aumento del 35% dell’uso delle piattaforme video tipo Netflix e la metà degli italiani ha seguito dirette streaming durante il lockdown. Il 71% delle famiglie ha effettuato acquisti online e un terzo degli italiani ha usato i servizi di food delivery. Il 17,5% degli italiani ha interagito per la prima volta in digitale con la pubblica amministrazione durante il lockdown. Si potrebbe continuare. Il sistema dell’informazione è da sempre al centro della trasformazione. Oggi, dopo il 2020, l’86,4% della popolazione cerca le notizie su internet, dice il Censis, e l’86% degli italiani è sui social network o sulla messaggistica istantanea.
Ma occorre cercare di comprendere che cosa significa tutto questo, al di là delle apparenze. Le punte dell’accelerazione sono abbaglianti, ma quello che ne resterà è problematico. Si è detto dello smart working: 3,5 milioni di probabili futuri smart worker sono quasi sei volte di più di quelli che c’erano prima del Covid-19, ma sono almeno quattro volte meno di quelli che, a quanto pare, l’hanno provato. Perché? Gli studenti che hanno seguito lezioni online sono 6,7 milioni, ma il 30% di loro ha avuto difficoltà di varia natura. Con quali conseguenze?
La tecnologia si è rivelata una soluzione indispensabile durante la crisi, ma non è necessariamente la soluzione preferita per tutti dopo la crisi. Con ogni probabilità, questo dipende, in misura tutta da definire, in parte dai difetti della tecnologia e in parte dall’impreparazione degli utenti italiani e dalla mancanza di stimoli a prepararsi di più. Gli italiani sono in media gli ultimi in Europa per quanto riguarda la conoscenza delle tecnologie digitali di base e avanzate, come registra il Digital Economy and Society Index europeo.
Molte teorie sono già emerse per riflettere su questi avvenimenti. Alcune osservazioni di base sono peraltro chiare, visti i risultati del 2020. Gli italiani digitalizzati sono aumentati. E dimostrano che la conoscenza della tecnologia, almeno come utenti, è correlata con una condizione economica e sociale di vantaggio: i digitalizzati sono quelli che stanno meglio. Gli italiani non digitalizzati sono restati tagliati fuori dall’economia nel pieno della crisi e restano meno preparati a recuperare dopo la crisi. La polarizzazione aumenta e aumenterà in assenza di un grande piano di formazione in materia, per i cittadini e soprattutto per le imprese.
Già, perché da quello che si comprende, non sono tanto i lavoratori che l’hanno provato a voler lasciare lo smartworking, a quanto si legge nell’attualissimo libro di Domenico De Masi, “Smart working” (Marsilio 2020), ma sono le aziende e i manager che non sanno organizzarsi in modo da cogliere le opportunità offerte dal lavoro da remoto. Non è che gli italiani non siano capaci di comprendere le tecnologie, tanto che una parte crescente le adotta con successo; è che molte organizzazioni in Italia sembrano gestite in modo poco compatibile con le logiche della codificazione, della programmazione, della preparazione anticipata, della progettazione visionaria, che consente di usare al meglio le tecnologie.
Di fatto, il digitale funziona meglio se le organizzazioni non si affidano a uno stile di gestione fondato sulle consuetudini e la prossimità, ma coltivano un approccio di management progettuale, strategico, aperto e ordinatamente procedurale. Di sicuro, l’agilità organizzativa degli italiani resta un valore, per la capacità di reazione e adeguamento al cambiamento che le organizzazioni italiane non cessano di dimostrare. Ma funziona sempre più limitatamente a un mondo locale, come da tempo spiega l’economista Enzo Rullani. Il vero carattere della cultura digitale è la sua capacità di aprire porte internazionali: vendere al vicino che ti conosce, come nei distretti che Rullani ha contribuito a far conoscere, è facile anche senza procedure codificate; ma approcciare mercati lontanissimi e persone che non si conoscono richiede procedure standard internazionali.
Le imprese che tengono in piedi l’economia italiana sono quelle che esportano e che non hanno cessato di esportare di più anche dopo la crisi del 2008: non mancano certo in Italia. Queste imprese esportatrici, digitalizzate, capaci di innovare e programmare, viaggiano alla velocità del mondo, il cui Pil è cresciuto dal 2000 del 177% mentre il commercio mondiale cresceva del 213%. Le imprese che non esportano restano confinate nelle pratiche locali, non necessariamente codificate, digitalizzate, innovative. L’andamento del Pil italiano dimostra ovviamente che mentre gli esportatori sono cresciuti, il resto è andato indietro.
Alla fine, la formazione è la via d’uscita: ma si può scommettere che lo stimolo per i cittadini a impegnarsi davvero in una grande campagna di educazione al digitale arriverà quando le imprese dimostreranno di averne compreso fino in fondo il potenziale. Il ricorso allo smart working sarà una cartina di tornasole: le imprese che si riorganizzeranno per utilizzarlo – e occupare in questo modo 3,5 milioni di persone – lo faranno passando a una pratica di gestione nuova, orientata alla programmazione e all’organizzazione progettata; le imprese che lo rifiuteranno lo faranno sulla base della convinzione che quello che sanno fare – e il loro modo di farlo – è sufficiente. I dati sembrano dimostrare che queste ultime hanno torto.
Ringraziamo Luca De Biase per il contributo.