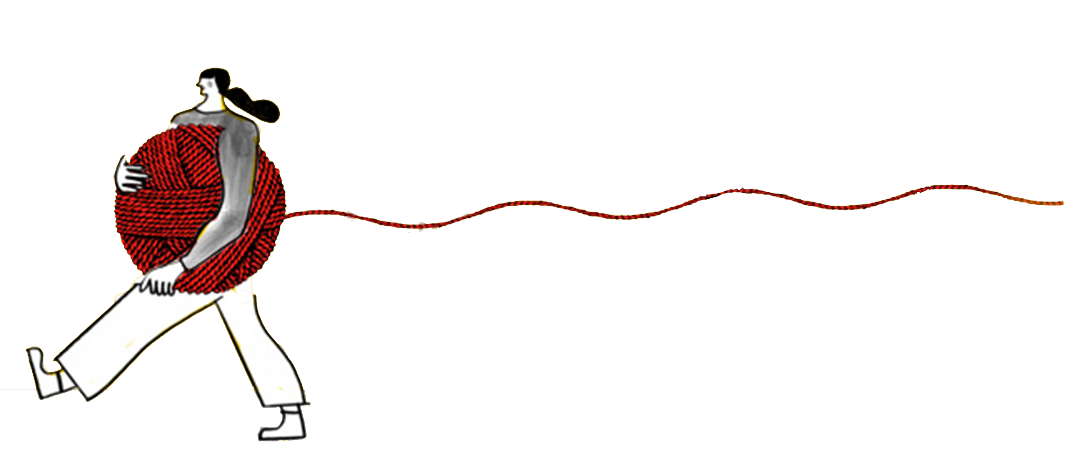Formazione, attivismo, inclusione. Intervista a Fabrizio Acanfora
Quando entra nel campo della Diversità, Equità e Inclusione, la formazione deve necessariamente dialogare con la storia, le pratiche e i concetti dell'attivismo. Un dialogo non sempre facile, per la differenza di linguaggi e prospettive, eppure prezioso per la costruzione di una società più giusta. Ne abbiamo parlato con Fabrizio Acanfora, autistico, attivista, scrittore, professore universitario e formatore, che tra questi mondi si muove.
Di recente, con la pubblicazione del progetto Non solo parole. Guida a una cultura condivisa, in collaborazione con Valore D, ci siamo ritrovatə sul rapporto tra formazione e attivismo. Se l’inclusione e il superamento di ogni forma di discriminazione sono sempre state al centro della mission formativa di Feltrinelli Education, questo progetto è stato anche l’occasione per approfondire questa relazione complessa tra formazione e attivismo, perché tanti dei concetti inclusi nel volume sono stati elaborati in ambienti politici e militanti. Concetti che noi abbiamo tentato di portare nel mondo delle imprese, provando a farci carico di quella tensione tra le rivendicazioni delle comunità marginalizzate e l’esigenza di incidere sui processi produttivi e gli ambienti di lavoro.
Il concetto di inclusione è del resto ormai centrale nel mondo del lavoro. Le organizzazioni che abbracciano la diversità nelle loro squadre tendono a essere più innovative e creative. Secondo un report di McKinsey & Company, le aziende con maggiore diversità di genere nei loro team esecutivi sono il 25% più propense a superare la media nazionale in termini di performance finanziaria. Inoltre, la diversità etnica incrementa questa probabilità al 36%. La varietà di prospettive e esperienze favorisce dunque un ambiente più fertile per nuove idee e soluzioni innovative.
Alla valorizzazione di questa ricchezza ci si può formare? E in che modo un progetto formativo può essere fedele alla forza e alla sostanza di concetti e rivendicazioni nate in seno alle pratiche e alle lotte di persone e comunità che fanno attivismo? Quali sono i limiti e i rischi di una formazione sull’inclusione che non si apre a una vera inclusione?
Ne abbiamo parlato con un intellettuale che da molti anni si muove tra questi due mondi: Fabrizio Acanfora, autistico, attivista, scrittore, professore universitario, pianista e formatore, nonché curatore - con Nadeesha Uyangoda - di Non solo parole.

Come è nato il suo percorso di attivista e come quello di formatore?
Sin da bambino ero insofferente verso le ingiustizie. Mi arrabbiavo molto di fronte a situazioni che percepivo come ingiuste e desideravo fare qualcosa al riguardo. Ho anche considerato la possibilità di entrare in politica, ma poi ho cambiato idea quando ho visto come funzionava. Dopo aver ricevuto la diagnosi di autismo, sono entrato in contatto con vari gruppi che fanno attivismo, questo è accaduto intorno al 2016 o 2017. In quel periodo ho scritto il mio libro "Eccentrico" (effequ, 2018), inizialmente senza l'intenzione di pubblicarlo, piuttosto come un modo per fare il mio "coming out". Ho notato una certa resistenza a questo coming out, soprattutto da parte di persone che pensavano che non potessi essere autistico perché parlavo o guardavo negli occhi. Iniziavo a capire quanta lavoro ci sarebbe stato da fare; tuttavia, ho continuato per la mia strada. Nel frattempo, ho iniziato a lavorare come coordinatore del master di musicoterapia a Barcellona e ho continuato a studiare, seguendo vari corsi, ma honotato che l’approccio prevalente verso l’autismo era quello medico, spesso patologizzante, deficitario. Io ho scritto il mio libro principalmente per spiegare alle persone intorno a me cosa significasse essere autistico provando a mostrare il punto di vista interno. Questo mi ha portato a fare delle presentazioni del libro, dove ho raccontato la mia storia a diverse platee, comprese persone autistiche, genitori di persone autistiche alla ricerca di risposte e persone che volevano semplicemente saperne di più sull'autismo. Ho iniziato a scrivere un blog e mi sono unito a Neuropeculiar, l’associazione di cui ora sono presidente. L'associazione è stata fondata da, Alice Sodi, persona autistica ed esperta di Disability Studies, come “Movimento per la Biodiversità Neurologica e che indica la tutela e la promozione dei diritti di autorappresentanza e autodeterminazione delle persone autistiche come principi statutari”. Il mio percorso di attivista è nato così.
E sul fronte della formazione, invece?
Il mio interesse verso l'attività di formatore è nato quasi per caso. Fin da giovane ho avuto una forte passione per l'insegnamento, l’ho sempre considerato un modo per capire meglio le cose. Il mio percorso scolastico è stato piuttosto tortuoso, iniziato con un forte interesse per la matematica durante le medie, per poi affrontare difficoltà crescenti dovute a uno stile di apprendimento differente, nel liceo scientifico,. Questo mi ha portato a cambiare scuola più volte anche a causa di difficoltà di integrazione con i compagni e di un interesse per la musica sempre maggiore.
Le mie esperienze con l'insegnamento formale sono iniziate durante i tirocini a scuola, in particolare nelle scuole elementari, dove ho scoperto di essere bravo e amato dai bambini. Contemporaneamente alle scuole superiori ho frequentato il Conservatorio, cosa che mi ha portato a dare lezioni private di pianoforte e fare supplenze di musica in varie scuole private. Per un anno ho insegnato in una scuola a Roma, esperienza che mi ha confermato quanto fosse gratificante trasmettere agli altri le competenze acquisite.
Il mio percorso ha preso una nuova direzione quando mi è stato chiesto di tenere lezioni sullo spettro autistico agli studenti del Master in musicoterapia dell’Università di Barcellona. Questo incarico nel master è stato decisivo per il mio approccio sistematico all'insegnamento.
Nel frattempo, ho conosciuto una esperta di risorse umane, che ha un figlio autistico. La nostra discussione su autismo e mondo del lavoro ha acceso il mio interesse per le dinamiche di inclusione lavorativa delle persone autistiche. Dopo aver iniziato a tenere webinar e incontri per aziende su invito di questa persona, sono stato assunto dall'azienda dove lavoro attualmente, specializzata nell'inserimento lavorativo di persone autistiche. In questa azienda, mi occupo non solo della comunicazione, ma anche della formazione aziendale, condividendo l'idea che l'inclusione non possa limitarsi alla formazione dellapersona autistica, ma richiede un impegno continuo anche da parte dell’azienda.
Parliamo allora di inclusione. Se nel mondo dell’attivismo si guarda a un superamento di questo concetto - lei parla di “convivenza della differenze” - in ambito aziendale esso appare ancora centrale. In che relazione si pongono attivismo e formazione rispetto a questo concetto? E in che modo comunicano questi due mondi?
Sul concetto di inclusione potrebbe effettivamente venire facile far convergere il mondo dell’attivismo e quello della formazione, perché entrambi puntano a un superamento delle barriere e delle marginalizzazioni. Eppure, al di là della definizione stessa di inclusione, che spesso risulta paternalistica, si tratta di due mondi molto differenti anche negli obiettivi.
Basti pensare che il linguaggio aziendale deve comunicare chiaramente gli obiettivi della formazione su diversità e inclusione: obiettivi specifici, dunque, definiti nell’interesse dell’azienda e non rivendicazioni. Indipendentemente dalle dinamiche messe in atto, l'obiettivo delle politiche di D&I è rendere l'ambiente aziendale più inclusivo, consentendo a un maggior numero di persone di lavorare efficacemente. Questo porta vantaggi sia all'azienda, aumentando la produttività, sia alle persone coinvolte. Del resto gruppi con background e caratteristiche diverse tendono ad essere più innovativi, come dimostra anche il Business Case per la D&I. Si tratta, insomma, di creare le condizioni per un lavoro produttivo rendendo l’ambiente favorevole. Questi obiettivi legittimi e importanti del mondo aziendale non coincidono completamente con quelli dell’attivismo, che nasce innanzitutto da una rivendicazione e che deve avere uno sguardo che va oltre l’ambiente lavorativo.
Per me è poi importante ricordare che l'inclusione non riguarda solo le minoranze; rendere il mondo del lavoro più accessibile beneficia tutti, inclusi coloro che si sentono esclusi dai metodi standard. Possiamo fare l’esempio di un on-boarding che segua procedure standard, e pensare a cosa succede alle persone non conformi - che non necessariamente appartengono a una precisa categoria minoritaria - quando si interfacciano con queste procedure standard. Come si interviene, in ottica inclusiva, su questi processi? Una buona formazione agisce a questi livelli e crea un ambiente più positivo e condiviso, ma resta una pratica differente dall’attivismo.
Quindi la formazione non diventa mai, in un certo senso, una pratica di attivismo?
Insegnare agli studenti di diversi percorsi o ai futuri terapeuti come interagire con persone autistiche potrebbe essere considerato attivismo. Tuttavia, il bilanciamento tra queste prospettive può essere complicato. Fare attivismo richiede un impegno totale, che potrebbe non essere compatibile con certi percorsi formativi perché richiede un posizionamento politico netto, cioè più radicale anche nel linguaggio. Spiegare il valore dell'inclusione in modo efficace è essenziale sia per le aziende che per le istituzioni e porta benefici reali, ma l'attivismo è lotta politica, per l'uguaglianza sociale, non necessariamente divulgazione. Va sempre considerato il contesto e l'obiettivo specifico della formazione, e più in generale di ciò che si fa. Stare in bilico tra questi due mondi, spesso, non è affatto facile.
E dunque cosa serve per formare su questi temi, oggi? Come si forma chi farà formazione?
La formazione in questo contesto deve essere particolarmente attenta, poiché non si tratta di insegnare una tecnologia o pratiche consolidate in azienda. Penso alla formazione su dinamiche come il metodo STAR, usato nei colloqui di selezione del personale. Questi corsi si inseriscono in un percorso di studi che può includere master in gestione delle risorse umane o percorsi accademici regolari, ma spesso presentano ancora delle mancanze. E per individuare queste mancanza, la disabilità è davvero una cartina al tornasole in questo senso, perché mostra chiaramente come nei corsi di Disability Management o Diversity Management determinate categorie sociali continuano a essere sotto-rappresentate., In molti casi argomenti come la disabilità in generale, o le neurodivergenze, vengono affrontati da specialisti (psicologi, medici) che portano però solo un punto di vista esterno, continuando a mancare il punto di vista interno alla categoria, l’autorappresentanza..
La presenza fisica delle persone sotto-rappresentate diventa essenziale, in fase formativa. La narrazione collettiva della società riguardo la disabilità spesso dipinge le persone disabili come soggetti di una tragedia o destinatari di carità. Allo stesso modo, l'immagine del superamento individuale è comune, come l'esempio di chi, nonostante le disabilità, riesce in imprese straordinarie. Questo tipo di narrazione alimenta un’idea fallace di merito e non riflette l'esperienza completa della persona disabile. È una narrazione che continua ad avere fortuna proprio perché per le persone con disabilità non c’è sufficiente spazio di auto-narrazione, soprattutto negli ambienti formativi.
Questo vale anche per le altre categorie minoritarie. Ad esempio, gli omosessuali sono spesso etichettati come particolarmente sensibili, una percezione che deriva da una comprensione superficiale e stereotipata. Allo stesso modo, la sordità è vista come una tragedia, senza considerare come in una società inclusiva si potrebbe insegnare a scuola la lingua dei segni insieme alle altre lingue, e ne abbiamo un esempio nella storia di Martha’s Vineyard.
Senza questa presenza autentica, la formazione rischia di perdere pezzi fondamentali e di appoggiarsi a narrazioni riduttive e paternalistiche. Durante la redazione di un libro o di materiali formativi, sarebbe ideale che il formatore o la formatrice affrontassero gli argomenti di cui non hanno esperienza diretta cercando un confronto con persone che vivono personalmente le esperienze oggetto di formazione: non è obbligatorio che un formatore faccia personalmente parte di un gruppo minoritario, ma è necessario che dalla fase progettuale il team sia equilibratamente composto anche da persone appartenenti a gruppi minoritari, che il loro punto di vista sia presente.
Spesso si parla di attivismo performativo, eppure a un’advocacy davvero efficace la comunicazione social è indispensabile. Come si utilizza al meglio senza farsi inghiottire?
L'attivismo sui social media, spesso etichettato come "performativo", è oggi oggetto di critiche. Personalmente trovo le dinamiche dei social difficili da gestire, e quindi la mia presenza è moderata. Bisogna rendersi conto che questi strumenti non sono neutrali, internet non è stato creato come uno strumento neutro, e lo stesso vale per i social network. Queste piattaforme, come Facebook, usano i contenuti degli utenti per la loro sopravvivenza, trasformando l'utente in un lavoratore non retribuito. Se non ci fossero i contenuti degli utenti, le piattaforme sarebbero solo aggregatori di annunci pubblicitari.
L'attivismo può diventare involontariamente performativo quando non ci si rende conto del rischio di essere utilizzati dalle piattaforme, che hanno obiettivi commerciali ben definiti. Spesso, per mantenere la visibilità, le persone sono costrette a produrre contenuti in continuazione, e questo può portare a un isolamento e a una diminuzione della qualità del pensiero critico. Anche in questo caso, quindi, si tratta di mantenersi su un equilibrio molto delicato.
L'attivismo dovrebbe essere un'azione collettiva e non isolata. Utilizzare gli strumenti digitali per creare consapevolezza e costruire una rete è oggi necessario, ma è fondamentale essere consapevoli delle dinamiche dietro le piattaforme e di come queste possono influenzare la nostra attività. Altrimenti si rischia di trasformarlo in un'industria, dove la visibilità è spesso premiata più della sostanza. Il mercato tende a favorire contenuti che piacciono alla maggioranza, a volte enfatizzando narrazioni polemiche o eccessivamente ottimistiche per attrarre l'attenzione.
L’attivismo sta vivendo un periodo estremamente delicato, per la sua espansione in rete. Chi fa attivismo dovrebbe formarsi adeguatamente all’utilizzo dei social media, ovvero comprendere le dinamiche sistemiche più ampie. Il desiderio di espandere le proprie comunità è giusto e importante, ma non bisogna mai perdere di vista il vero scopo collettivo del proprio impegno.
Pensiamo al meme “Tre uomini con il papillon parlano di aborto”, da BoJack Horseman. Chi era abituato ad avere il monopolio della parola, dice che oggi non si può più dire niente. Nella comunicazione il background di chi parla è infatti ormai un elemento essenziale di legittimazione del discorso. Vale anche per la formazione?
Come già accennavamo, uno dei problemi della formazione sta proprio nella scarsa presenza di relatori e relatrici che possano presentare una prospettiva autentica e informata sulla realtà che stanno cercando di spiegare. Senza questa presenza, c'è il rischio che la formazione si riduca a una narrazione paternalistica e disconnessa dalla realtà, portando a interventi che non affrontano veramente le esigenze e le aspirazioni delle persone coinvolte.
La partecipazione nelle decisioni e nella narrazione deve essere realmente e profondamente inclusiva. Ciò che si richiede e che spesso viene travisato non è che solo le donne parlino di temi di loro interesse e che gli uomini parlino solo per gli uomini, e così per qualsiasi altra categoria, inclusi gli autistici. Il punto cruciale è che la narrazione dev’essere corale e valorizzare equamente l'esperienza di tutti, evitando di ridurre la partecipazione di qualcuno a un mero simbolismo. Non basta mostrare un progetto finito e chiedere un semplice sì o no a un rappresentante della minoranza di turno. La vera inclusione implica la partecipazione delle minoranze fin dall'inizio del processo decisionale.
Non si riflette mai abbastanza sul fatto che senza cambiare la narrazione e renderla veramente inclusiva, questa rimarrà parziale e sbilanciata e non inciderà nella coscienza di chi la riceve. Non è necessario evocare termini come patriarcato o razzismo per riconoscere che molte distorsioni narrative e privilegi sono spesso inconsci. Da appartenente ad alcune categorie minoritarie, osservo come si proceda spesso senza consapevolezza di questi bias, come se si avanzasse con carri armati, ignorando le reali condizioni di partenza degli altri. Si dà tutto per scontato, si normalizzano queste ingiustizie.
La sociologia dell’inavvertito ci insegna come ciò che non viene esplicitato diventa la norma; ciò che è normale lo è anche perché non viene messo in discussione, perché è percepito come abituale. Ad esempio, alcune persone cisgender reagiscono negativamente all'essere etichettate come tali, dimostrando così la sensibilità alle etichette quando queste le vengono applicate dall’esterno, rivelando una mancanza di consapevolezza delle dinamiche di potere preesistenti.
È davvero fondamentale che ogni voce sia ascoltata e considerata fin dall'inizio di qualsiasi processo, sia esso decisionale o formativo. Che ogni voce prenda parte a pieno titolo e con pari dignità al discorso comune.